Cos'è Pesach?
Pagina 1 di 6
Alle origini della festa
La durata della festa
Riflessioni sul significato di “essere liberi”
Perché il termine “Pesach” viene tradotto con “Pasqua”
Come ci si prepara ad accogliere la festa
L'insieme dei testi riportati qui sotto sono integralmente tratti dal libro "Le pietre del tempo, il popolo ebraico e le sue feste" di Clara ed Elia Kopciowski (edizione Ancora 2001).
Alle origini della festa
Circa 3200 anni orsono Giacobbe, insieme ai suoi figli e alle loro famiglie, si trasferì in Egitto per raggiungere il figlio Giuseppe che ne era divenuto viceré.
I discendenti di Giacobbe divennero assai numerosi, ma non dimenticarono il monoteismo insegnato loro da Abramo. Ciò creò quella che forse potemmo definire la prima manifestazione di Xenofobia, diffidenza ed odio verso i diversi, della storia. Xenofobia che sfociò una vera e propria persecuzione. Un Faraone, probabilmente di altra dinastia rispetto a quella del Faraone che aveva elevato Giuseppe alla carica di viceré, dapprima ordinò che i figli di Israele fossero ridotti in schiavitù usufruendo gratuitamente della loro opera. In un secondo tempo dato che essi, nonostante il duro lavoro, continuavano ad aumentare di numero, diede ordine che tutti i loro figli maschi furono uccisi al momento della nascita.
Jocheveth, una donna ebrea della tribù di Levi, non volle sottostare passivamente all’ordine: prese il bambino e lo mise in un cesto che affidò alla corrente del Nilo nella speranza che un qualche evento miracoloso lo salvasse dalla morte.
La figlia di Faraone vide il fanciullo e, nonostante si fosse probabilmente resa conto che doveva trattarsi di un bambino ebreo, fu presa da grande pietà, lo accolse e lo fece crescere a corte come un figlio. Quel bambino era Mosè: il nome Mosè significa, infatti, “salvato dalle acque”.
Divenuto adulto Mosè andava spesso a fare visita e a recar conforto ai suoi fratelli schiavi. Una volta s’imbatté in un egiziano che, sicuro della propria impunità, maltrattava un povero vecchio: ne risultò una colluttazione durante la quale l’egiziano rimase ucciso.
E’ assai probabile che, se lo avesse richiesto, Mosè avrebbe ottenuto il perdono del Faraone che, pare, gli fosse molto affezionato. Ma forse in lui stava maturando quello spirito profetico che avrebbe informato tutta la sua vita: le ingiustizie, la corruzione, l’immoralità che regnavano in Egitto, soprattutto a corte, lo avevano certo profondamente colpito e ora aveva bisogno di un periodo di riflessione, lontano dal palazzo reale, perché la coscienza gli imponeva di rendersi conto di quale fosse effettivamente il proprio compito e il proprio ruolo nella vita.
Attraverso il deserto e si fermò a Midian dove prese le difese di sette pastorelle, figlie di Jetro sacerdote di Midian, dalla prepotenza di alcuni pastori. Dallo stesso Jetro fu invitato a fermarsi a lavorare presso di lui. Mosè divenne così pastore, e sposò una delle figlie del sacerdote midianita, Zippora.
Le due esperienze, quella di personalità di spicco alla corte di Faraone e quella di pastore a contatto con gente umile dedita al lavoro, furono fondamentali nella formazione del suo carattere preparandolo al suo futuro ruolo di capo, ma anche di padre e protettore del suo popolo.
Fu proprio durante il periodo in cui Mosè era pastore presso il suocero che “Dio udì i loro gemiti e vide i figlioli di Israele ed ebbe compassione della loro condizione” (es. 2, 24-25). Apparve perciò a Mosè in un roveto ardente che pur bruciando non si consumava, e gli ordinò di tornare in Egitto per “fare uscire” i figli di Israele dal giogo degli egiziani promettendogli che gli sarebbe sempre stato vicino, e che avrebbe inviato al suo fianco il fratello Aharon perché lo aiutasse.
Il Faraone non prese in nessuna considerazione la richiesta di Mosè di lasciare andare il popolo di Israele, nonostante questi avesse messo in guardia della potenza del “Dio di Israele”.
Si riversarono allora sull’Egitto dieci piaghe con effetti devastanti su tutto il paese: le acque del Nilo e di tutte le sorgenti dell’Egitto si trasformarono in sangue; seguì una invasione di rane, poi quella di una quantità di insetti dannosi. Sopravvenne quindi una invasione di ogni genere di bestie feroci che fece strage di uomini e di bestiame.
Invano lo stesso popolo egiziano chiese a Faraone di lasciar libero il popolo ebraico per ottenere cessazione dei flagelli: in un primo momento il Faraone premetteva di obbedire alla volontà divina ma, non appena la piaga cessava, si rifiutava di mantenere la promessa.
La gravità delle piaghe si fece sempre più intensa: gli egiziani furono colpiti dalla pestilenza, ricoperti di bubboni, investiti da terribili tempeste, invasi da una miriade di locuste e infine da una profonda oscurità che coprì per giorni e giorni l’Egitto senza mai lasciar spazio a uno spiraglio di luce.
L’ultima piaga fu terribile: l’angelo della morte, in una livida notte di terrore, si aggirò fra le case degli egiziani colpendone a morte tutti i primogeniti, anche quello di Faraone.
Il Faraone fu così costretto, infine, a dare agli ebrei il permesso di lasciare l’Egitto.
I figli di Israele, dopo aver consumato il sacrificio pasquale – un agnello col sangue del quale avevano segnato gli stipiti delle loro abitazioni per segnalarle all’angelo della morte che infatti “passò oltre” risparmiando i loro primogeniti – si affrettarono ad abbandonare l’Egitto così come era stato loro ordinato: “E mangiatelo in questa maniera: coi vostri fianchi cinti, coi vostri calzari ai piedi e col bastone in mano. Mangiatelo in fretta: è la Pasqua dell’Eterno” (Es 12,11).
Prima della loro partenza, gli egiziani offrirono agli ebrei doni in oro e argento, forse come risarcimento per il lavoro gratuito svolto per tanti anni. Gli Ebrei accettarono i doni e, come vedremo in seguito, fecero male.
L’Eterno ordinò che zevach pesach, il “sacrificio pasquale”, fosse consumato la prima sera di Pesach da tutte le generazioni future, perché mai gli avvenimenti di allora, così densi di significato e di insegnamenti, venissero dimenticati.
Ma gli ebrei dovevano aver costituito, durante la lunga permanenza nel paese, una colonna portante sia per il contributo di lavoro, sia per quello delle idee, visto che ancora una volta il Faraone si pentì della sua decisione: “Che cosa abbiamo fatto a lasciar libero il popolo di Israele che ora non ci servirà più?” (Es 14,5).
Alla testa del suo esercito li inseguì per riportarli indietro provocando al proprio popolo quella che potremmo definire l’undicesima piaga, quella che probabilmente è rimasta più famosa: l’apertura del Mar Rosso attraverso la quale gli ebrei raggiunsero salvi la riva opposta, mentre gli egiziani, che avevano tentato di attraversarla dopo di loro, furono inghiottiti dalle acque che si richiudevano e affogarono.
Pagina 2 di 6
La durata della festa
Il 14 di Nissan veniva offerto il sacrificio pasquale al Tempio. Solo la sera, che per la tradizione ebraica è già il 15 di Nissan, inizia la festa vera e propria con una cerimonia speciale chiamata seder. In Israele Pesach dura sette giorni, fuori di Israele otto. Ciò è dovuto al fatto che, anticamente, nella diaspora, non era facile far pervenire tempestivamente l’esatta data delle ricorrenze; quindi, per evitare errori, le si faceva durare un giorno in più. L’uso è stato mantenuto, nonostante oggi non manchi la possibilità di comunicare tempestivamente la data di inizio della festa, per sottolineare la differenza tra coloro che vivono in Israele e coloro che ne vivono fuori.
Il calendario ebraico (…) è basato sui cicli della luna, non ci permette di fissare per le feste una data precisa nel calendario solare.
Pagina 3 di 6
Riflessioni sul significato di “essere liberi”
La festa ha inizio al tramonto del 14 di Nissan, che corrisponde circa al mese di aprile.
Pesach, il momento in cui il popolo dei figli di Israele diviene il popolo libero, rappresenta per gli ebrei il simbolo della libertà.
Libertà: una parola difficile che si presta a molteplici interpretazioni e anche a più di un abuso.
La libertà può riguardare il singolo individuo, o interi popoli; può riguardare lo spirito o il corpo.
Esiste anche un concetto assai individualistico di libertà, intesa come possibilità di fare tutto quel che si vuole senza regole né limiti, indipendentemente dai diritti e dalla libertà degli altri.
In che modo ognuno di noi è responsabile della propria, o dell’altrui libertà? Fino a che punto e con quali modalità siamo tenuti a batterci per la nostra, o per l’altrui libertà, senza lasciarci prendere da un assurdo senso di orgoglio che può trasformarci in arroganti arbitri del comportamento altrui, o da un senso di opaca rassegnazione che, rimandando a Dio ogni responsabilità sul comportamento umano, ci consente di lasciare le cose come stanno senza partecipare personalmente alla liberazione di chi è schiavo e oppresso?
Schiavo o oppresso da chi, o da che cosa?
Esiste una libertà morale che coinvolge la nostra coscienza di essere creati “a immagini di Dio” e ci impone un totale rispetto verso noi stessi e verso gli altri. Ma esiste anche una libertà materiale, libertà dalla miseria e dal bisogno, che prevede il diritto a una vita decorosa e dignitosa quale patrimonio indispensabile perché ogni essere creato possa mantenere intatto il rispetto verso se stesso e, di conseguenza, verso il prossimo: ed è questo l’insegnamento base che troviamo nella Torah la cui consegna segue immediatamente l’uscito del popolo ebraico dall’Egitto proprio perché l’improvvisa libertà non degeneri in abuso o sopruso.
Cominciamo a scindere il problema in due parti: la libertà del corpo e la libertà dello spirito. La prima, se si affida unicamente all’istinto non illuminato della ragione e dall’insegnamento, e qui ci riferiamo proprio all’insegnamento della Torah, è paragonabile alla libertà degli animali non illuminati dal “discernimento fra il bene e il male”, e che seguono quindi soltanto il proprio istinto e i loro appetiti.
Ma è purtroppo propria anche di tanti uomini che hanno fatto della forza bruta, dell’imposizione indiscriminata della propria volontà su quella degli altri, che non solo è abuso, ma che si perde facilmente non appare all’orizzonte un uomo più potente e più prepotente.
La vera libertà è la seconda, quella spirituale. L’uomo, o il popolo, che l’abbia fatta propria, che l’abbia resa parte integrante di se stesso, è libero in eterno e nessuno, mai, potrà più renderlo schiavo. (…)
Pagina 4 di 6
Perché il termine “Pesach” viene tradotto con “Pasqua”
Pesach deriva del verbo ebraico Pasoah che significa “passare oltre”, e si riferisce all’episodio terrificante in cui l’angelo della morte, durante la notte della decima piaga, si fermò nelle case degli egiziani colpendone tutti i primogeniti, ma pasach, “passò oltre”, le case degli ebrei sugli stipiti delle quali, in segno di riconoscimento, era stato spruzzato del sangue dell’agnello sacrificale.
Verso il VI secolo prima dell’Era Cristiana, in tutto il mondo mediorientale si diffuse una nuova lingua, l’aramaico. Molti fra gli stessi ebrei adottarono l’aramaico come lingua corrente, e in aramaico il termine Pesach è tradotto con Pascha. L’attinenza fra le due parole, Pascha e Pasqua, è evidente.
Pagina 5 di 6
Come ci si prepara ad accogliere la festa
Ogni festa ebraica richiede un’accurata preparazione che coinvolge soprattutto la donna: ma quella di Pesach necessita di un impegno particolare.
E’ scritto: “Per sette giorni mangerete pane azzimo, ma prima che giunga il primo giorno toglierete dalle vostre case ogni lievito; osserverete quindi questo giorno in tutte le vostre generazioni” (Es 12, 15-17).
Per rivivere nel tempo il momento fatidico della loro liberazione dalla schiavitù e della loro nascita a popolo libero, gli ebrei mangiano tuttora ogni anno a Pesach, per sette giorni (fuori di Israele otto), il pane azzimo. E’ facile comprendere come l’ordine di eliminare dalla casa ogni tipo di sostanza lievitata imponga alla donna il dovere di compiere un’accuratissima pulizia della casa. Un impegno che peraltro le donne eseguono con entusiasmo e con estrema spolverando, lavando ogni recondito angolo dei mobili, dei ripostigli, e di tutta la casa, per prepararla a introdurvi il pane azzimo, cioè il pane non lievitato che in ebraico si chiama matzah.
La ragione per cui a Pesach gli ebrei mangiano pane azzimo è da rintracciarsi nel fatto che uscirono così frettolosamente dall’Egitto che non ebbero il tempo per fare lievitare il pane. Se poi esaminiamo la storia e gli usi dell’antico popolo di Israele, possiamo scoprire nel pane non lievitato significati assai più profondi e mistici: il pane azzimo era quello che il sommo sacerdote mangiava sull’altare durante i sacrifici. Secoli dopo divenne il pane comunemente usato dalla setta mistica degli esseni.
Evidentemente l’antica civiltà ebraica aveva un certo rifiuto per il lievito forse perché, essendo il risultato della fermentazione di un impasto di farina, gli faceva perdere le caratteristiche di un alimento puro, trasformandolo in cibo impuro: esso assume perciò nella concezione ebraica il simbolo di quel che non deve essere, in pratica simbolo del male. Interessante a questo proposito notare l’attinenza fra i nomi hametz, “cibo lievitato”, e hamas, “violenza”, quindi ingiustizia e immoralità. Il far scomparire dalla casa ogni genere di cibo lievitato va quindi interpretato anche come un invito a sgomberare il nostro animo da ogni tipo di hametz, o di hamas, da ogni residuo di odio, di rancore, di violenza, di corruzione, per presentarsi liberi e puri dinanzi al Signore, degni pertanto di offrire il zevach pesach, il “sacrificio pasquale” (che però dopo la distruzione del secondo Tempio non è stato più possibile compiere in forma concreta).
I Maestri della Mishnah, la legge orale che accompagna e completa la legge scritta, prescrivono inoltre che durante i giorni di Pesach, per evitare qualsiasi dubbio o possibile trasgressione, vengano usati stoviglie da tavola e recipienti da fuoco diversi da quelli del resto dell’anno; recipienti che vengono accuratamente conservati da un anno all’altro in un luogo in cui non abbiamo mai occasione di venire a contatto con i cibi proibiti di Pesach.
Per le donne, particolarmente per quelle strettamente osservanti, la preparazione del Pesach divenne quindi un impegno piuttosto gravoso e stressante anche in considerazione dei brevi tempi che intercorrono fra l’eliminazione del lievito e il cambio di tutte le stoviglie di Pesach. D’altronde proprio l’accuratezza di questo allestimento sottolinea il valore della festa.
Ma è fondamentale, a nostro avviso, ricordare che l’osservanza dei precetti non deve mai essere fine a se stessa correndo il rischio di trasformarsi in superstizione. Il suo vero scopo è quello di richiamare alla memoria l’importanza determinante di quanto la festa ci insegna.
Pagina 6 di 6
Il Seder
La prima sera di Pesach (le prime dure sere fuori di Israele) le famiglie ebraiche si riuniscono intorno a un tavolo apparecchiato in modo particolare, per celebrare il Seder, una cerimonia durante la quale di legge la Haggadah, il racconto dell’uscita degli ebrei dall’Egitto, arricchito di midrashim (parabole) e commenti dei Maestri, e seguito da una cena che si conclude con canti corali di inni e melodie che si tramandano di generazione in generazione, di luogo in luogo.
(…) Il Seder è una cerimonia di alto valore pedagogico sotto molteplici aspetti. A ogni commensale, per sottolineare il senso della libertà appena acquisito, è permesso di sedere a tavola senza osservare le strette regole dell’etichetta: si possono appoggiare i gomiti sul tavolo, o sdraiarsi comodamente sulle seggiole, cose che i commensali adulti in genere, per vecchia abitudine, evitano di fare, ma che rende estremamente felici i bambini che assaporano a loro modo il primo senso di libertà.
Sul tavolo apparecchiato viene posto in cesto contenente tre pane azzimi (matzah), in ricordo del pane non lievitato mangiato nel deserto, una zampa d’agnello (pesach), in ricordo del zevach pesach, il sacrificio pasquale compiuto dal popolo che si accingeva a uscire dalla schiavitù, e dell’erba amara (maror), diversa a seconda delle tradizioni e della provenienza di chi celebra il Seder, in ricordo dell’amarezza patita dagli ebrei in schiavitù.
Il maror simboleggia forse il passo più importante verso la conquista della libertà. Dalle amarezze del passato, che lasciate fermentare, “lievitare” nell’animo e nel cuore, avrebbero potuto trasformare il popolo ebraico in un popolo crudele e vendicativo , è stato invece tratto un insegnamento basilare: è necessario affrontare la vita con una più consapevole e serena visione del rapporto fra gli uomini, è indispensabile volgere il cuore e l’animo con profondo affetto e comprensione verso i poveri, gli oppressi, i sofferenti.
Dalle amarezze della schiavitù è nato un inestinguibile odio per la schiavitù, la nostra, e quella di qualunque creatura, e un altrettanto inestinguibile amore per la libertà a cui ogni essere umano ha diritto e che, unica, permetterà ai figli di Israele anche in futuro di sopravvivere per adempiere alla missione.
Prima della distruzione del Tempio, ogni famiglia che andava in pellegrinaggio a Gerusalemme vi portava il suo agnello del sacrificio che poi veniva arrostito e mangiato. Ma da quanto il Tempio è stato distrutto e i sacrifici interrotti, i Maestri hanno deciso che, per ricordare la gravissima perdita, durante la cena di Seder non venga servito nessun tipo di carne arrostita.
Oltre a questi tre simboli di Pesach (pesach, matzah, maror), nel cesto vi è un uovo sodo, il charoseth, un impasto preparato anch’esso secondo ricette che variano a seconda delle tradizioni dei vari luoghi di provenienza, e che simboleggi la malta che gli ebrei schiavi erano costretti a preparare in Egitto per fabbricare i mattoni con cui avrebbero edificato la città del Faraone. Per il Seder però la malta si trasforma in un dolce impasto di frutti: datteri, noci, mandorle e altro per sottolineare la fine della schiavitù. Vi è poi del sedano (carpas), che deve essere intinto in acqua e sale, o in acqua e aceto: probabilmente una specie di aperitivo in vista della cena.
Sul tavolo viene posto, oltre al bicchiere destinato al Kiddush, alla santificazione della festa attraverso il vino e il pane, un altro bicchiere d’argento pieno di vino destinato al profeta Elia. La tradizione vuole infatti che il profeta, durante la prima sera di Pesach, si aggiri fra le case degli ebrei per portare i suoi voti augurali alle famiglie che celebrano il Seder, e ognuno spera di far parte dei privilegiati che riceveranno la sua visita.
La visita è tanto più attesa in quanto la tradizione afferma che sarà proprio il profeta Elia ad annunciare al mondo il giungere dell’Epoca messianica. E ogni ebreo vive la speranza che l’Epoca messianica, l’epoca della pace, dell’armonia, dell’amore fra tutti i popoli, sia proprio lì, dietro la porta di casa, porta che infatti, durante il Seder, viene lasciata aperta anche perché è detto: “chi vuole entri, mangi e celebri Pesach”.
Forse l’uso si riallaccia anche al Talmud in cui è scritto: “Nel mese di Nissan fummo redenti, e nel mese di Nissan siamo destinati a essere redenti” (Rosh ha-shanah 11).
Val la pena soffermarsi un momento sul significato dell’uovo sodo. Per l’ebraismo esso ha un valore tutto particolare. L’uovo è infatti il primo cibo che si offre a coloro che sono in lutto per la perdita di un parente stretto, in quanto è il simbolo della vita che si appresta a nascere, in opposizione alla morte. Perciò nel momento in cui il nostro animo è in preda alla disperazione e ci pare di non poter trovare né conforto né consolazione a una perdita irrimediabile, esso ci insegna che la vita che vive in noi è un dono che Dio ci ha concesso, e che in questo dono dobbiamo trovare la forza di continuare la nostra opera.
Inoltre l’uovo non ha spigoli, perciò non ha né un punto di inizio né un punto di fine. Così la sua rotondità, proprio nel momento in cui pare che con la morte sia tutto finito, ci ricorda che la vita è un ciclo che, come l’uovo, non ha né inizio né fine: chi dai propri cari ha ricevuto la vita e gli insegnamenti, chi lascia dietro di sé il dolore dei figli ai quali ha trasmesso la vita e gli insegnamenti, continua a vivere attraverso di loro.
Ed è questo il modo umano di conquistare l’eternità.
Il segno del lutto che noi aggiungiamo al festoso cesto del Seder, e che per tradizione viene consumato da tutti i primogeniti maschi (ma se anche altri ospiti vorranno associarsi, potranno farlo) è un triste ricordo degli innocenti figli primogeniti degli egiziani, vittime della cieca ostinazione del Faraone. Proprio per questa ragione è il primogenito ebreo che, per dimostrare il proprio dolore per la morte dei fratelli egiziani, usa mangiare l’uovo sodo.
Per la medesima ragione i maschi primogeniti, il giorno precedente il Pesach, fanno digiuno.
Dicevamo che il Seder è molto importante anche dal punto di vista pedagogico: dopo il Kiddush il primo intervento è riservato al commensale più giovane o, in coro, ai più giovani; si tratta del Mah nishtannah: “come è diversa questa serata da tutte le altre sere!”. Il canto è composto da quattro domande che il bambino rivolge agli adulti: “Perché tutte le altre sere mangiamo pane, e questa sera azzima? Perché tutte le altre sere mangiamo qualsiasi tipo di verdure, e questa sera erba amara? Perché tutte le altre sere non intingiamo (riferito al sedano intinto in acqua e sale o aceto) neppure una volta, e questa sera due volte? Perché tutte le altre sere mangiamo seduti, e questa sera sdraiati?”.
Le domande danno il via alle risposte, impartito attraverso la lettura della Haggadah che narra gli eventi miracolosi legati all’uscita dall’Egitto.
Durante il Seder si devono quattro bicchieri di vino in memoria delle quattro espressioni usate da Dio quanto preannuncia a Mosè la prossima liberazione del popolo: “li sottrarrò” dalle sofferenze dell’Egitto “; “li farò uscire” dal luogo di schiavitù; “li redimerò e li prenderò come mio popolo”. Esse rappresentano i vari stadi della libertà appena riconquistata che vanno elevandosi a sempre maggior livello fino a raggiungere la santità di “li prenderò come mio popolo” (Es 6,7).
La Torah aggiunge una quinta espressione: e “li farò entrare nella terra promisi ai loro padri” (Es 6,8). Non può esistere in effetti una completa libertà morale se non è legata a una libertà di comportamento, possibile solo in uno stadio proprio e indipendente.
Durante la lettura della Haggadah vengono nominate le dieci piaghe che hanno colpito l’Egitto e per ognuna di essa si versa un po’ di vino contenuto nel bicchiere in un recipiente: ciò sia per augurarci che queste disgrazie siano sempre lontane da noi e dalle nostre famiglie; sia per ricordare che nessuna gioia può essere completa se è costata lutti e dolori ad altri; sia, infine, per auspicare che mai più si ripeta una situazione in cui un popolo meriti di essere colpiti da tanti flagelli.
Un momento particolarmente interessante, e psicologicamente e pedagogicamente assai valido, è quello dedicato alla lettura del brano riguardante i “quattro figli”: il sapiente, il semplice, colui che non è capace neppure di domandare, e il figliolo cattivo.
I quattro figli rappresentano i vari tipi di cui l’umanità è composta e il testo della Haggadah ci fornisce importanti suggerimenti sul tipo di risposta da dare ad ognuno di essi.
Al saggio, cioè colui che pone una domanda acuta e complessa, si deve dare una risposta adeguata, dotta e approfondita, che non deluda né sottovaluti l’intelligenza e la capacità di apprendimento di chi domanda.
Al semplice occorre dare una risposta chiara e comprensibile per permettergli di capire pienamente il senso di quanto gli si sta spiegando, stimolandolo possibilmente a far nuove domande.
Particolarmente importante è l’insegnamento che viene impartito al figlio che non è in grado di porre domande; ci dice infatti la Haggadah: “A colui che sa domandare, aprigli tu la bocca!”. Importante notare che nella frase “apri tu”, il “tu” è espresso al femminile, “apri” al maschile. È la madre la prima insegnante del bambino, tocca quindi soprattutto a lei, fin dall’inizio, seguire con la massima attenzione il suo sviluppo mentale: ma è il padre che deve coadiuvare e sostenere sua moglie in questa opera. Se ne conclude che solo la collaborazione fra padre e mandre permette un normale, sereno sviluppo del carattere infantile.
Inoltre, se un bimbo si mostra totalmente disinteressato al mondo che lo circonda, non fa domande e non si pone interrogativi, se dà segno di isolarsi e di non partecipare in alcun modo alla vita attorno a lui, lungi dal rallegrarsi per il “buon carattere” del bambino che non disturba, “aprigli la bocca”, sollecita cioè la sua curiosità, coinvolgilo nei fatti che accadono per renderlo vivo, interessato e partecipe, aiutandolo quindi a crescere e a entrare in modo intelligente e attivo nella società.
Intrigante e piuttosto ironica è la risposta destinata a quel figlio che nella Haggadah viene nominato per secondo: il figlio “malvagio”, che forse rientra più nella categoria dei figli contestatari che in quella di veri e propri “cattivi”.
Egli chiede: “Che cosa significa questa cerimonia (il Seder) per voi?”; domanda in cui sottolinea: “Per voi, e non per me!”.
Si pone in questa maniera, con una certa arrogante superiorità, totalmente al di fuori del gruppo.
Suggerisce la Haggadah: “Tu rispondigli risentito (letteralmente “fagli digrignare i denti”); “Se tu fossi stato presente al momento della salvezza, non saresti stato salvato!”.
Una riposta apparentemente impietosa.
Ma riflettiamo sui motivi che spingono tante volte i giovani, e non sempre a torto, a contestare certi atteggiamenti, certi usi ereditati e forse non sufficientemente o logicamente spiegati. Nostro compito è quello di chiarire per dar loro modo di comprendere. Ebbene, con la frase incisiva “tu non saresti stato salvato” la Haggadah chiama il giovane a una responsabilità personale facendogli rivivere in prima persona, oggi, il momento drammatico della schiavitù. Ecco, gli dice la Haggadah, se tu, che adesso siedi con noi libero, e puoi parlare liberamente dell’epoca della schiavitù, tu che oggi contesti e rifiuti le responsabilità insite del passato, ti fossi trovato insieme ai nostri primogeniti a scegliere fra schiavitù e libertà, con tutte le responsabilità che tale scelta comportava, forse avresti vigliaccamente scelto di continuare a servire Faraone. In tal modo non avresti meritato la salvezza e oggi saresti ancora schiavo.
La Haggadah non accenna però all’esistenza di un quinto figlio; quello che non c’è perché si è staccato da ogni forma di tradizione e si è perso.
A qualsiasi tipo di domanda, anche a quella del contestatore, può essere data una risposta, risposta che può essere discussa, che può arricchire chi lo fa e chi la riceve con nuove interpretazioni non necessariamente in antitesi o in contrasto con quelle precedenti, ma persino innovative e progressiste.
Ma il figlio che non è presente è perso.
Il Seder finisce con una lunga serie di canti corali tradizionali composti da molte strofe, la cui caratteristica precipua è quella della ripetizione, alla fine di ogni strofa, di una frase: quella che tutti i commensali per tradizione conoscono meglio e quindi cantano a gran voce con grande entusiasmo.
In ultimo viene intonato il canto l’anno prossimo tutti a Gerusalemme, ricostruita, e viene distribuito l’afikomen, preparato nella parte iniziale del Seder, che simboleggia il sacrificio pasquale e che deve essere consumato quando si è già sazi.
http://www.comunitadibologna.it/index.php?option=com_content&task=view&id=83&Itemid=99999999&limit=1&limitstart=5
giovedì 9 aprile 2009
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)


































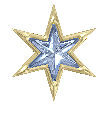










Nessun commento:
Posta un commento