Israele affronta la sua storia
di Eric Rouleau *
Negli anni '80, è iniziata, nell'intellighenzia israeliana, una
profonda mutazione, legata all'arrivo di una nuova generazione di
uomini e donne che non hanno conosciuto la Shoah né la creazione dello
stato d'Israele. Un'evoluzione che testimonia anche della progressiva
maturazione di élite ormai capaci di giudicare senza complessi il
passato e di liberarsi da miti e tabù trasmessi dai dirigenti
israeliani.
L'anticonformismo di questi intellettuali - storici, sociologi,
filosofi, scrittori, giornalisti, cineasti, artisti - fa la sua
comparsa nel periodo successivo alla guerra dei sei giorni, nel 1967;
ad alimentare la contestazione sono l'occupazione, la resistenza
palestinese, l'ascesa al potere della destra nazionalista e religiosa
nel 1977, la crescente influenza di coloni e rabbini espansionisti,
nonché l'esacerbarsi delle tensioni tra clericali e laici. «Quando
parlano di Tel Aviv, i religiosi dicono spesso Sodoma e Gomorra,
mentre, per i laici, Gerusalemme, è la Tehran degli ayatollah»,
osserva Michel Warschawski, uno dei dirigenti dell'ala radicale del
movimento pacifista.
La pace con l'Egitto, nel 1979, suscita la speranza di un ordine
globale, che l'invasione del Libano delude nel 1982. Quest'ultima,
vissuta dall'opinione pubblica come la prima guerra offensiva di
Israele, è stata scatenata per ragioni rivelatesi false.
Contrariamente a quanto sostenuto dal governo israeliano,
l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp), che il
tandem Menahem Begin - Ariel Sharon cercava di annientare, non aveva
messo in atto alcuna provocazione. Al contrario, mostrava già di
volersi impegnare sulla via del compromesso. E comunque, non metteva
in pericolo l'esistenza dello stato ebraico. All'epoca, molti
israeliani si sono scandalizzati per l'estrema brutalità del loro
esercito, per il numero esorbitante di vittime tra i civili
palestinesi e libanesi, fino ad arrivare allo spaventoso massacro di
Sabra e Chatila, compiuto alla luce del sole dalle unità di Tsahal.
Avvengono allora fatti senza precedenti: ben quattrocentomila persone
manifestano al centro di Tel Aviv; cinquecento ufficiali e soldati
disertano; il movimento dei refuznik dà voce a coloro che rifiutano di
servire nell'esercito, prima in Libano, poi nei territori occupati.
La «purezza delle armi», vanto dello stato ebraico fin dalla sua
nascita, è seriamente compromessa.
Alcuni giovani storici contribuiscono, più o meno consapevolmente, a
gettare discredito sullo slogan. Prendendo visione degli archivi
ufficiali, ampiamente messi a disposizione nel 1978 - trent'anni dopo
lo svolgimento dei fatti in oggetto, come vuole la legge israeliana
- , scoprono che il comportamento delle forze armate israeliane, prima
e durante la guerra del 1948, non corrisponde minimamente all'immagine
idilliaca diffusa dalla propaganda. Il primo che, basandosi su
documenti ufficiali, pubblica un libro che elenca i «sette miti
principali» utilizzati per decenni per ingannare l'opinione pubblica
(1), è Simha Flapan, uno dei dirigenti del partito di sinistra Mapam e
fervente sionista fino alla sua morte.
Esporre e analizzare le conclusioni di coloro che vengono comunemente
indicati come i «nuovi storici» (2) è l'obiettivo del libro di
Dominique Vidal (in collaborazione con Sébastien Boussois). Si tratta
di ricercatori che, per la prima volta dalla creazione dello stato
d'Israele, fondano i loro lavori non su informazioni di seconda mano,
come i loro predecessori, ma su documenti incontestabili presi negli
archivi del consiglio dei ministri, dell'esercito, del Palmach (truppe
d'assalto), delle organizzazioni sioniste e dai diari del primo
ministro e ministro della difesa David Ben Gurion, tra gli altri. Il
libro descrive così le circostanze che conducono alla guerra contro
gli eserciti arabi, stigmatizza il ruolo, quanto meno ambiguo, di Ben
Gurion, poi dedica un capitolo a Benny Morris, il capofila dei «nuovi
storici», che definisce «schizofrenico» a causa del divario tra il suo
impegno, in quanto storico alla ricerca della verità, e le sue
posizioni politiche vicine all'estrema destra israeliana.
Analizza infine l'ultimissima opera di Ilan Pappé, Le Nettoyage
ethnique de la Palestine, che provocò un tale scandalo - dopo tanti
altri - che il suo autore dovette dare le dimissioni dall'università
di Haifa e andare in esilio presso un'università britannica.
«Rendere la Palestina ebrea, quanto l'America è americana e
l'Inghilterra è inglese» Pappé non è il primo intellettuale
dissidente, e sicuramente non sarà l'ultimo, a espatriare per
sfuggire, scrive, all'ambiente soffocante che circonda gli «appestati»
come lui. Eppure, è molto difficile contestare le sue ricostruzioni,
molto più dettagliate di quelle dei suoi predecessori. Lo storico di
Haifa, infatti, ha avuto accesso a nuovi documenti, tratti dagli
ultimi sessant'anni degli archivi israeliani (e non dagli ultimi
quaranta, come, per lo più, i suoi predecessori). Ma si è anche basato
sugli scritti di storici palestinesi, spesso testimoni oculari degli
avvenimenti. E ha raccolto le testimonianze dei sopravvissuti alla
pulizia etnica, fino ad allora stranamente trascurati dai suoi
colleghi o per aprioristico rifiuto delle testimonianze, o per
diffidenza, o ancor più banalmente, per ignoranza della lingua araba -
testimonianze tanto più preziose, in quanto gli stati arabi a
tutt'oggi rifiutano di aprire gli archivi ai ricercatori.
Le divergenze tra Pappé e Morris non sono, in ultima analisi,
veramente fondamentali. L'uno e l'altro confermano prima di tutto che
la guerra del 1948 non è stata, come si è preteso, un combattimento
tra «David e Golia», perché le forze israeliane erano nettamente
superiori, per effettivi e armamenti, ai loro avversari. Nel pieno
della guerra civile israelo-palestinese, si contarono solo alcune
migliaia di combattenti palestinesi, mal equipaggiati e spalleggiati
dai volontari arabi dell'Esercito di liberazione condotto da Fawzi Al
Qawuqji.
E, anche quando, il 15 maggio 1948, entrarono in campo gli stati
arabi, i loro contingenti erano di molto inferiori a quelli della
Hagana, che peraltro in seguito continuò a rafforzarsi. Inoltre, i due
storici concordano, gli eserciti arabi hanno invaso la Palestina in
extremis (e alcuni a malincuore), non per «distruggere il giovane
stato ebraico», cosa di cui si sapevano incapaci, ma per impedire che
Israele e la Transgiordania - in «combutta», secondo lo storico Avi
Shlaim - suddividessero tra loro il territorio destinato ai
palestinesi dal piano di spartizione dell'Onu del 29 novembre 1947.
«Siamo in grado di occupare tutta la Palestina, ne sono certo»,
scriveva Ben Gurion a Moshe Sharett già nel febbraio 1948, ossia tre
mesi prima della guerra israelo-araba e poche settimane prima della
consegna di un massiccio quantitativo di armamenti inviati, via Praga,
dall'Unione sovietica. Il che non gli impedì di continuare a
proclamare che Israele era minacciata da un «secondo Olocausto».
Travolto dall'euforia per le vittorie riportate, riferisce Pappé, il
«padre» dello stato ebraico, già nella prima settimana di guerra (il
24 maggio), scriveva nel suo diario personale: «Costituiremo uno stato
cristiano in Libano (...). Distruggeremo la Transgiordania,
bombarderemo la sua capitale, annienteremo il suo esercito (...).
Metteremo in ginocchio la Siria (...). La nostra aviazione attaccherà
Port Said, Alessandria e il Cairo, e così vendicheremo i nostri
antenati oppressi, all'epoca biblica, dagli egiziani e dagli assiri...
» Morris e Pappé sfatano anche la leggenda, accuratamente coltivata
dai dirigenti israeliani, secondo cui i palestinesi avrebbero lasciato
volontariamente le loro case, in seguito agli appelli lanciati dalle
autorità e dalle radio arabe (trasmissioni inventate di sana pianta
dalla propaganda israeliana, come dimostrano le registrazioni
integrali realizzate dalla British Broadcasting Corporation [Bbc]). Al
contrario, i due storici confermano quel che già si sapeva dalla fine
degli anni '50: sono state le stesse autorità israeliane a costringere
i palestinesi all'esodo, ricorrendo ai ricatti, alle minacce, al
terrore e alla brutalità delle armi per cacciarli dalle loro terre.
Divergono, invece, sul senso di queste espulsioni: per Morris, sono
solo «danni collaterali»; «la guerra è guerra», spiega, aggiungendo,
più recentemente (3) e non senza cinismo, che Ben Gurion avrebbe
dovuto espellere fino all'ultimo palestinese. Laddove Morris descrive
un esodo «nato dalla guerra, e non dalla volontà israeliana o araba»,
Pappé dimostra che la pulizia etnica è stata pianificata, organizzata
e messa in atto per estendere il territorio dello stato d'Israele e
«ebraicizzarlo».
A ragion veduta. Perché, sebbene i dirigenti sionisti avessero
pubblicamente approvato il piano di spartizione proposto dalle Nazioni
unite, in realtà lo ritenevano inaccettabile: la loro era
un'approvazione di tipo tattico, come dimostrano sia numerosi
documenti d'archivio che il diario di Ben Gurion.
Certo, a loro era stata attribuita più della metà della Palestina,
mentre il resto spettava agli arabi autoctoni, sebbene fossero due
volte più numerosi degli ebrei. Tuttavia - ed era questo il problema
- , il territorio previsto per lo stato d'Israele sembrava loro troppo
piccolo, per i milioni d'immigrati che i dirigenti speravano di
accogliere; per di più, quattrocentocinquemila arabi palestinesi vi
avrebbero convissuto con cinquecentocinquantottomila ebrei, il che
voleva dire che questi ultimi avrebbero costituito solo il 58% della
popolazione del futuro stato ebraico. Il sionismo rischiava così di
perdere totalmente la sua ragione d'essere: «Rendere la Palestina
ebrea, quanto l'America è americana e l'Inghilterra è inglese»,
secondo la formula di Haim Weizmann, futuro primo presidente
d'Israele.
Ecco perché il «trasferimento» (eufemismo che sta per espulsione)
degli arabi autoctoni fuori dalle frontiere era il pensiero fisso dei
dirigenti sionisti, che ne dibattevano continuamente, di preferenza a
porte chiuse. Fin dalla fine del XIX secolo, Theodor Herzl aveva
suggerito al sultano ottomano di deportare i palestinesi per fare
spazio alla colonizzazione ebrea. Nel 1930, Weizmann rifece la stessa
proposta al governo britannico, la potenza mandataria della Palestina.
Nel 1938, dopo la proposta di un mini-stato ebraico, accompagnata dal
trasferimento degli arabi prevista dalla commissione britannica
diretta da lord Peel, Ben Gurion dichiara davanti al comitato
esecutivo dell'Agenzia ebraica: «Sono favorevole a un trasferimento
obbligatorio, una misura che non ha niente d'immorale». La guerra del
1948 doveva offrirgli l'occasione sognata per mettere in atto il suo
progetto, lanciando contro la popolazione autoctona, sei mesi prima
dell'intervento degli eserciti arabi, l'offensiva destinata a
sradicarla. Per fare questo, rivela Pappé, si serviva di un archivio
relativo a tutti i villaggi arabi, con informazioni demografiche ed
economiche, ma anche politiche e militari, uno schedario messo in
piedi dall'Agenzia ebrea a partire dal 1939 e costantemente aggiornato
durante gli anni '40.
I mezzi ai quali le forze israeliane hanno fatto ricorso - che Pappé
analizza nel dettaglio - fanno venire i brividi, anche se non sono
diverse dalle atrocità commesse nel corso di epurazioni etniche
condotte da altri popoli fin dalla più remota antichità. Il bilancio
effettuato dallo storico è eloquente: in pochi mesi, sono state
recensite diverse decine di massacri e di esecuzioni sommarie;
cinquecentotrentuno villaggi (su un migliaio), distrutti o
riconvertiti per accogliere immigrati ebrei; undici centri urbani,
etnicamente misti, svuotati dei loro abitanti arabi...
Ed infatti è sulla punta delle baionette che tutti i palestinesi di
Ramleh e di Lydda, settantamila persone, bambini e vecchi compresi,
sono cacciati in poche ore, a metà luglio del 1948, su istruzioni di
Ben Gurion. Ne fanno fede le Memorie (ulteriormente censurate) del
futuro primo ministro Itzhak Rabin, all'epoca ufficiale superiore,
incaricato, con Yigal Allon, dell'operazione. Ricacciati verso la
frontiera della Transgiordania, molti di loro muoiono di sfinimento
per strada. Lo stesso era avvenuto, in aprile, a Jaffa, dove
cinquantamila abitanti arabi avevano dovuto fuggire, terrorizzati dal
cannoneggiamento dell'artiglieria dell'Irgun e dalla paura di nuovi
massacri. È quel che lo stesso Morris chiama il «fattore atrocità».
Servire la causa della pace, ristabilendo la verità sull'ingiustizia
commessa nel 1948 Questi orrori sono tanto più ingiustificati, in
quanto molti villaggi arabi, a detta di Ben Gurion, avevano proclamato
la loro volontà di non opporsi alla suddivisione della Palestina e
alcuni avevano anche concluso in questo senso accordi di non-
belligeranza con i loro vicini ebrei. Come nel caso di Deir Yassin,
dove, nonostante tutto, le forze irregolari dell'Irgun e del Lehi
(«banda Stern») massacrarono una gran parte della popolazione - con,
secondo Flapan, il tacito accordo dell'esercito «regolare»
dell'Agenzia ebraica, l'Hagana.
Complessivamente, tra settecentocinquantamila e ottocentomila
palestinesi dovettero prendere la strada dell'esilio dal 1947 al 1949,
mentre i loro beni mobili e immobiliari venivano confiscati. Secondo
la stima di un ufficiale israeliano citato da Vidal, il Fondo
nazionale ebreo s'impadronì di trecentomila ettari di terre arabe, di
cui dette l'essenziale ai kibbutz. L'operazione non poteva essere
meglio concepita: all'indomani del voto dell'Assemblea generale delle
Nazioni unite, l'11 dicembre 1948, sulla famosa risoluzione del
«diritto al ritorno», il governo israeliano adotta la legge d'urgenza
relativa alle proprietà degli assenti che, completando quella del 30
giugno 1948 sulla coltura delle terre abbandonate, legalizza
retroattivamente la spoliazione e proibisce ai derubati di rivendicare
una qualsiasi compensazione e di tornare alle loro case.
Nonostante le proteste di alcuni membri del governo israeliano,
scandalizzati dalla brutalità della pulizia etnica, Ben Gurion - che
non l'aveva esplicitamente ordinata per iscritto - non fa niente per
interromperla o condannarla. Si limita a denunciare i saccheggi e gli
stupri ai quali si abbandonavano alcuni soldati di Tsahal, i quali
beneficiarono tuttavia di una totale impunità. Ma la cosa forse più
sorprendente, è il pesante silenzio della «comunità internazionale»
per diversi decenni, quando gli osservatori stranieri, compresi quelli
dell'Onu, non potevano certo ignorare le atrocità commesse. Si capisce
meglio, allora, perché i palestinesi commemorano la Nakba
(«catastrofe»), e non la «guerra d'indipendenza d'Israele», che il
recente Salone del libro parigino ha scelto di celebrare.
Ricollegandosi agli storici della guerra del 1948, Avi Shlaïm,
professore di lunga data al St Antony's College di Oxford, ha appena
pubblicato Le Mur de fer. Israël et le monde arabe. Vi distrugge un
altro mito: quello di uno stato d'Israele amante della pace, che si
scontra con il bellicismo degli stati arabi decisi a distruggerlo. Il
titolo del libro è tratto dalla dottrina di Zeev Jabotinsky: fin dal
1923, questo padre della destra ultranazionalista sosteneva che
bisognasse rinunciare a trattare un accordo di pace prima di aver
colonizzato la Palestina al riparo di un «muro di ferro», perché gli
arabi avrebbero capito solo la logica della forza. Avendo adottato
questa dottrina nella pratica, uomini politici e militari israeliani,
di sinistra come di destra, avrebbero in generale sabotato i
successivi progetti di pace. Ritenendo che il tempo gioca a favore di
Israele, con la pretesa che quest'ultimo non abbia «partner per la
pace» (dixit Ehoud Barak), i dirigenti di Gerusalemme aspettano sempre
che la parte avversa si rassegni ad accettare l'espansione
territoriale dello stato ebraico, il frazionamento e la
demilitarizzazione di un ipotetico stato palestinese, condannato a
diventare un mosaico di bantustan satellizzati. Il libro di Shlaim, la
cui edizione inglese nel 2000 è stata un successo (più di
cinquantamila copie vendute), è stato tradotto in molte lingue prima
di essere stampato in ebraico cinque anni più tardi: la quasi totalità
degli editori israeliani l'aveva fin lì considerato «privo di
interesse». Comunque, Shlaim ammette di «riconoscere la legittimità
del movimento sionista e quella dello stato d'Israele nelle frontiere
del 1967».
Precisa tuttavia: «In compenso, rifiuto totalmente il progetto
coloniale sionista oltre questa frontiera». Con alcune eccezioni,
storici, sociologi, scrittori, giornalisti e cineasti che appartengono
alla nuova ondata dell'intellighenzia sono, come lui, sionisti di un
genere nuovo, soprannominati i «postsionisti». Tutti sono convinti di
servire la causa della pace ristabilendo la verità storica e
riconoscendo i torti inflitti ai palestinesi.
Per capire il senso e la portata di questa mutazione iniziata negli
anni '80, è interessante leggere l'inchiesta condotta da Boussois in
Israele, sia tra i «nuovi storici» che tra i loro avversari (4).
Alcuni ne concluderanno che la realizzazione di uno stato d'Israele
«normalizzato», in pace con i suoi vicini, dipenderà in gran parte
dall'impatto che avranno questi intellettuali contestatari sulla
società, e soprattutto sul mondo politico israeliano. È quello che
scrive, a suo modo, Yehuda Lancry, ex ambasciatore d'Israele in
Francia e negli Stati uniti: «i "nuovi storici", anche attraverso il
radicalismo di Ilan Pappé, sono altrettanti esploratori della parte
oscura della coscienza collettiva israeliana, sono coloro che
preparano una più convinta adesione al mutuo riconoscimento e alla
pace con i palestinesi. Il loro lavoro, lungi dal rappresentare una
fonte di problemi per Israele, fa onore al loro paese - e, ancora di
più: è un dovere, un obbligo morale, una prodigiosa presa in carico di
un'impresa liberatoria capace d'iscrivere nel vissuto israeliano le
linee di rottura, gli interstizi salutari, necessari all'inserimento
del discorso dell'Altro (5)».
note:
* Giornalista, ex ambasciatore di Francia.
(1) The Birth of Israel: Myths and Realities, Pantheon Books, New
York, 1987. Purtroppo, quest'opera pionieristica non è stata tradotta
in francese.
(2) Comment Israël expulsa les Palestiniens costituisce un'edizione
attualizzata e ampliata dell'opera Le Péché originel d'Israël,
pubblicato dallo stesso autore in collaborazione con Josef Algazy
(L'Atelier, 1998).
(3) In un'intervista al quotidiano Haaretz, Tel Aviv, l'8 gennaio
2004.
(4) In Comment Israël..., op. cit. Boussois è peraltro l'autore di
Israël confronté à son passé, L'Harmattan, Parigi, 2008.
(5) Prefazione a Comment Israël..., op. cit.
(Traduzione di G. P.) AVRAHAM BURG Vaincre Hitler. Pour un judaïsme
plus humaniste et universaliste (Fayard, Parigi, 2008, 359 pagine, 23
euro) ILAN PAPPÉ Le Nettoyage ethnique de la Palestine (Fayard,
Parigi, 2008, 394 pagine, 22 euro) in it.: La pulizia etnica in
Palestina (Fazi, 2008, 19 euro) AVI SHLAìM Le Mur de fer. Israël et le
monde arabe (Buchet-Chastel, Parigi, 2008, 759 pagine, 29 euro) in
it.: Il muro di ferro. Israele e il mondo arabo (Il Ponte Editrice,
2003, 29 euro) DOMINIQUE VIDAL Comment Israël espulsa les Palestiniens
(1947-1949) (L'Atelier, Ivry-sur-Seine, 2007, 256 pagine, 21 euro)
Da Le Monde Diplomatique di maggio 2008
http://groups.google.com/group/it.cultura.storia/browse_frm/thread/07a6b5d42f55b5ea?hl=it#
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)


































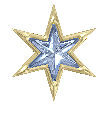










Nessun commento:
Posta un commento